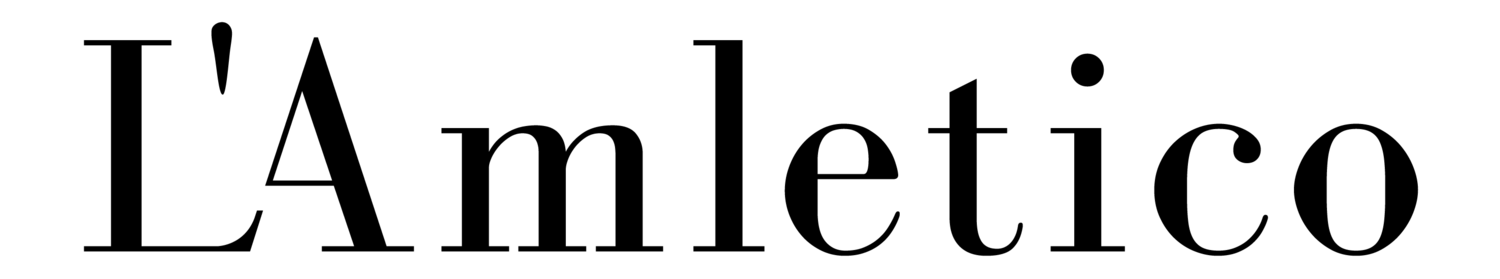Caravaggio, Pasolini e la “Roma” che non passa…
Quanti di noi sono ormai saturi di vedere e leggere ovunque i nomi di Caravaggio e Pasolini? Sbandierati, ostentati, evocati anche solo di sfuggita pur di catturare l’attenzione del pubblico. I loro nomi sono diventati parole magiche; dettagli delle loro opere – scorci chiaroscurali dall’afflato divino, o fotografie di ragazzi che giocano in un campetto dove si prende il tetano – bastano a far scattare la leva dell’interesse.
Ho scelto di mettere a confronto Caravaggio e Pasolini perché, più di chiunque altro, rappresentano due poli fissi dell’immaginario culturale romano. Sono ovunque: citati, evocati, riproposti senza sosta, diventati scorci obbligati ogni volta che si vuole raccontare la città. E non è solo una questione di fama: entrambi incarnano un dramma biografico che si è fuso con la loro opera, una vita ai margini, segnata da violenza, desiderio, scandalo, contraddizione. Proprio per questo sono diventati figure-mito, personaggi che il mileu romano utilizza come baluardo. È da questa sovraesposizione, da questa presenza quasi rituale, che nasce l’idea del parallelo: due stagioni culturali che ritornano sempre, due nomi che non smettono mai di essere convocati e forse incrociati.
È triste dover continuamente rincorrere la loro immagine per rendere appetibile una mostra o un evento. Non rende giustizia nemmeno agli autori stessi, trasformati in passe-partout, in semplici specchietti per le allodole. Si tenta di glorificare la storia della città, sempre più ridotta a un cartonato da film (anzi, da serie TV), attraverso grandi nomi utilizzati come decorazione: non solo neo-divi del web improvvisatisi attori, o cantanti di fortuna che appaiono e scompaiono come eclissi e nuove lune, ma anche volti marmorei ed eterni, perfetti per la Città Eterna.
In questa città ovidiana, dove il Rinascimento vive una metamorfosi che lo muta in Barocco, ci si può davvero opporre a questa pietrificazione che trasforma ogni volto in una maschera? I sempiterni e sempreverdi idoli della cultura romana… non saranno forse diventati i nuovi Re Mida?
Stanche etichette, voraci brand
Le loro immagini sono ovunque: moltiplicate, osannate, esasperate fino a diventare manifestazioni di fanatismo. Nulla di religioso in tutto questo – solo una perversione commerciale. Caravaggio e Pasolini sono diventati baluardi per destre e sinistre, simboli contesi anche da comunità diverse, che cercano di tirare uno da una parte e strattonare l’altro dall’altra. È un carnaio culturale, una gara per attribuire un significato ultimo, per piantare la propria bandierina, per far sventolare il proprio vessillo. Peggio ancora: proliferano i detective dell’“ultimo dettaglio”, gli Sherlock Holmes del micro indizio, alla ricerca della verità definitiva nel documento d’archivio smarrito o nel quadro falsamente attribuito che farebbe scricchiolare tutto ciò che si credeva di sapere.
Intanto si susseguono ri-edizioni e re-visioni, riproposizioni continue di opere e immagini.
Dove arriveremo a questo ritmo?
Se a volte lo “sguardo” su questa eredità culturale appare vagamente diverso, è solo perché, partendo sempre dallo stesso riferimento, non si può essere letterali in tutto. Eppure i motivi ricorrenti provengono sempre dallo stesso calderone: una zuppa riscaldata. È passata da mesi la mostra di Caravaggio a Palazzo Barberini, che ha avuto un enorme successo. Ma quante persone saprebbero distinguere un Caravaggio da un’opera di Artemisia Gentileschi – altro nome onnipresente – o da uno dei tanti caravaggeschi? Quanti saprebbero riconoscere un verso di Pasolini rispetto a quello di un altro intellettuale del periodo?
In fondo, parliamo di autori che per decenni sono rimasti di nicchia e che ora sono diventati iper-commerciali. Perché? Perché le differenze non le fa più nessuno: vince il brand, e la neo-mitologia commerciale che li ha trasformati in modelli prefabbricati. Il gay tormentato Pasolini, il passionale-violento Caravaggio: ognuno si compra la personalità che più combacia con il proprio modo d’essere. I tradizionalisti e repressi amanti della “bellezza” caravaggesca, i disinibiti e artefatti amanti della nuda “bruttezza” pasoliniana, si scambiano di posizione, si guardano in una stanza degli specchi dove incontrano le scuole, le famiglie, le istituzioni. E non sono solo due etichette: ce ne sono infinite. Etichette logore, sclerotiche, che si scollano dall’opera e vengono immediatamente riattaccate con un pezzo di scotch. Senza queste etichette, però, non si interessa nessuno – perché nessuno capisce più niente.
La bellezza, oggi, cosa c’è di più relativo? È un concetto criptico: siamo soggetti al suo potere seduttivo, ma non controlliamo i modi in cui questa bellezza viene impiegata. Certo, ci si lascia catturare dal gioco di luci e ombre di Caravaggio, dalla violenza del cinema pasoliniano (soprattutto delle opere più tarde e ispirate).
Ma alla fine, dietro ogni citazione deve sempre emergere Roma: la città del turismo archeologico dell’occidente che vuole diventare la città-monumento del turismo dei brand culturali. E questo è il loro Pantheon, un imbuto in cui si scivola con più facilità se si tengono gli occhi alzati, estatici, davanti all’idolo del momento.
André Gide, nei Sotterranei del Vaticano, mette in scena una Roma farsesca: fatta di traffici loschi, bluff creativi, ossessioni spettacolari e slanci vitalistici. Pasolini e Caravaggio non raccontano Roma bene quanto questo romanzo. Se si volesse davvero riscoprire la città attraverso occhi che l’hanno vivificata, bisognerebbe leggere Gide e arrivare all’ultima pagina del finale aperto. Nessun monumento, nessuna mitologia rimpianta, nessuna decadenza romanticizzata: solo le possibilità infernali e inesauribili di ciò che, in ogni momento, può tradire e tradirsi, piegarsi e ripiegarsi in sterile esercizio.
In quelle pagine si narra – tra le altre cose – di un’associazione segreta chiamata “Il Millepiedi”, che organizza una truffa legata alla Chiesa. Un verme che si ripiega su sé stesso diventa l’immagine di un presente che non vuole rinunciare alla presa sul reale. Ma, a differenza del lombrico, il millepiedi ha un’infinità di minuscole zampe, con cui riesce perfino ad aggrapparsi al soffitto. L’Uroboro è il serpente simbolo dell’infinito; questo insetto, invece, è un essere mortifero, radicato nella terra fredda. Bisogna rovesciarlo: solo così si può dire di non voler restare schiavi di una farsa senza fine.
Ci sono solo le mezze stagioni
I luoghi comuni sono semplificazioni mendaci, ma a volte possono diventare più presentabili se li si capovolge. Se a livello climatico viviamo un’alternanza sempre più estrema tra estati e inverni, sul piano culturale, secondo me, accade l’opposto.
Propongo questa provocazione: se Pasolini è l’autunno, Caravaggio è la primavera.
Il primo porta sempre con sé un senso di raccolta nostalgica attorno alla sua morte e a un’intera stagione intellettuale. Si cita di continuo il cliché dei ragazzi di vita, certo, ma anche nei momenti più sensuali o lirici prevale una malinconia di fondo (anch’essa diventata oggetto di un feticismo ricorrente).
Il secondo, invece, inaugura sempre una nuova stagione espositiva, quella che dovrebbe “rinnovare” l’offerta culturale dei musei della capitale. La sua morte, pur tragica, è più lontana e appare ormai inscritta nella leggenda. Così, il suo nome dà il via a una fioritura di piccole mostre, convegni ed eventi a tema: da un lato i “Caravaggio e…”, dall’altro i “Tizio sconosciuto e i caravaggeschi”. Il suo nome è diventato una pietra di paragone: sembra che chiunque abbia avuto un contatto – anche minimo, effimero, immaginato – con la sua persona o con la sua ombra. Basta un frammento di opera intravisto in un’acquaforte allegata a una lettera, mostrata a una cena, macchiata di vino: anche questo misero aneddoto diventa “storia”.
È proprio perché manca una ciclicità organica che non c’è mai una vera rinascita. Senza una presa simbolica, prende forma un nuovo tipo di monumentalismo: un monumentalismo senza simbolo, un infinito privo sia di trascendenza sia di immanenza, una pagina bianca su cui non si riesce a scrivere perché ogni segno si espande o viene risucchiato fino a scomparire. Roma non passa. Se le immagini sfocate di Caravaggio e Pasolini restano nella storia e nell’immaginario collettivo, è in filigrana che si rivela il vero profilo della città: quello dei suoi interessi economici e commerciali. Sono quelli, oggi, a essere vivi; il “capitale culturale” si riduce a un capitale di valori a buon mercato, che rifornisce continuamente le stesse riflessioni fino a esaurirle.
E cosa rimane di un terreno fertile dopo anni di monoculture?
È vero: i grandi scrittori, registi e artisti hanno prodotto opere inesauribili, attraversabili da molteplici punti di vista e capaci di offrire prospettive sempre nuove. Ma queste prospettive non vivono da sole: le opere non possono stare sotto campane di vetro, così come non possono vivere eternamente sui cartelloni pubblicitari.
Perché un’opera ritrovi la propria vita interna, deve donare parte della propria carica vitale alla vita culturale in cui è inserita – quella che la precede e quella che la segue – creando una catena, un chiasmo tra passato e futuro, un abbraccio trans-temporale.
Solo così possiamo risalire da questo pozzo monumentale, il cui fondo non si vede perché sembra non finire mai. Ma una fine, invece, serve: senza fine non c’è movimento. La catena a cui ci arrampichiamo deve vibrare, deve mostrare un minimo rischio d’instabilità; soltanto così possiamo intravedere il fondo, la cui immagine si costruisce nella paura stessa di cadere. Non bisogna temere la fine: nessuna fine è un termine assoluto. La fine è necessaria per interrompere le transazioni economiche e gli interessi che rendono sterile questo mercato dell’estetica e del sapere; serve a destabilizzare le sue logiche, e infine a permettere il ripristino di nuove coordinate del sentire.