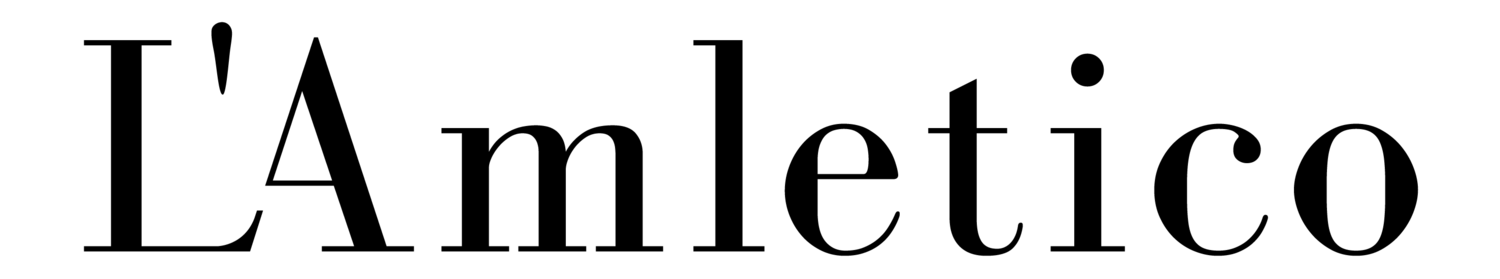Friedrich Dürrenmatt, “Greco cerca greca”
Premessa: sono di parte, poiché amo moltissimo Dürrenmatt e leggerei con gioia qualunque suo scritto, purché non si tratti di gialli e polizieschi (amanti del genere non abbiatevene a male, ma non è cosa per me). Perciò immaginate il mio entusiasmo quando ho scoperto che la cara Adelphi, dalla carta che aggrada il tatto, pubblicava l’anno scorso un nuovo romanzo dello scrittore svizzero, che non fosse un giallo, in questa seducente veste verde pastello!
Dirò qui, confessandolo pubblicamente, di esser convinto che il caro Dürrenmatt ci abbia lasciato dei veri e propri capolavori: “La morte della pizia”, il “Minotauro” e anche “La panne”, libriccini piccolini (tutti pubblicati da Adelphi in uniforme livrea rossa), che in poche pagine sconvolgono il lettore e lo sprofondano in riflessioni - o rivelazioni - di rara sagacia.
Oltre alla brevità, due caratteristiche compositive contraddistinguono i tre romanzi elencati: la capacità di riplasmare il mito come se fosse una creta cedevole, ma senza cambiarne la sostanza (“La morte della Pizia”, “Minotauro”); un mefistofelico sarcasmo che sparge ombre con il sorriso (“La morte della Pizia”, “La panne”).
In questo “Greco cerca greca” Dürrenmatt sfrutta l’uno e l’altro, il mito e il sarcasmo, condensandoli in un ennesimo breve romanzo, tanto gradevole da sentirmi autorizzato a consigliarne la lettura a chiunque (e dal momento che ho ricevuto qualche osservazione in merito alla “tragicità” dei libri che di solito recensisco, ecco che felicemente mi ritrovo a parlare di un romanzo che mi ha profondamente divertito, e successivamente intenerito e che, per una volta, non fa disperare).
Il greco di cui si parla è Arnolph Archilochos, un pingue nessuno dal lavoro insignificante e dall’esistenza anonima, retta dalla geometria dell’«ordinamento del mondo», in sette parti, che egli stesso ha eretto appendendo nella sua squallida soffitta i ritratti di sette persone incarnanti, per lui, ideali etici immutabili.
L’impressione iniziale è quella di trovarsi davanti un personaggio già conosciuto, un ultimo sfrortunello della commedia dell’arte, una maschera anche un tantino grottesca che gli autori furbi sfruttano come specchio del mostruoso «uomo medio», il quale, come certi animali davanti al proprio riflesso, non si riconosce, anzi!, ride di gusto, consuma il prodotto e gli assicura un imperituro successo.
Perciò, si può forse dire che ridere leggendo - in questo caso si sta parlando di libri - è un atto estremamente pericoloso: di cosa si ride?
L’autore volgare sfrutta il principio di riflessione dell’immagine per produrre quella comicità immediata, subito condivisibile, che accomuna in fratellanza tutti i ridenti sulla faccia della terra, ma che spesso appiattisce i temi e i personaggi smussandone i volumi fino alla liscia superficie specchiante. Peggio ancora è quando i gai ridenti credono di ridere pensando, di ridere riflettendo su grandi temi, mentre stanno solo ridendo della mediocrità di se stessi.
L’autore di qualità, invece, mira ad un obiettivo diverso, ovvero ad inviare frasi solleticanti all’organo dell’intelligenza, per stimolarlo a produrre quella piacevole sensazione che fa arricciare le labbra. Non si parla di volgare comicità, infatti, ma di ironia, di sarcasmo, insomma, di un divertimento meno sfacciato, più sottile, che non passa per l’immediato specchio mostruoso ma per la via più felice della comprensione. Ridere, sorridere, ridere leggendo - libri di qualità - è quella sintesi felice fra l’intelligenza dell’autore e l’intelligenza del lettore.
Poc’anzi dicevo di quanto Arnolph il greco sembri in apparenza una tipica maschera teatrale, ma Dürrenmatt è un autore di rara qualità e compie il prodigio di rendere il suo personaggio non l’ennesimo succube della Sfortuna, bensì indicibilmente fortunato!
Più abituati al primo canonico caso, quindi pronti a prevederne gli effetti, nel secondo noi lettori sgraniamo gli occhi e sospettiamo. La Sfortuna è tanto più accettabile in quanto più comune e ciò che, in definitiva, spesso tocca di sopportare agli uomini, mentre la fortuna è talmente rara che, soprattutto quando così profusamente elargita, genera un inevitabile sospetto.
Per gran parte del libro il lettore assiste all’ascesa del greco, un’ascesa tanto fulminea e gratuita da avere ogni caratteristica dell’incombente rovina. La rovina è ciò che il lettore attende con certo timore, consapevole di quanto sia distruttiva col crescere delle vette alle quali Arnolph giunge. Ed in effetti essa giunge alla fine di pagine magistrali per ritmo serrato e caotico, come una corsa affannata. Solo, giunge estremamente differente rispetto a quella attesa, una rovina così lieve (ma così spaventosa per Arnolph) da dar l’impressione che tutto il breve romanzo sia in realtà una farsa. Il climax ascendente delle vicende, sempre più vicine a quella comicità buffonesca che anzi lambiscono, oltre al sospetto in parte confermato, pur in attesa di qualcosa di “più grosso”, dello sconquasso finale, aggiunge un sospetto sul significato del libro: che cosa ci sta raccontando?
Trattandosi di Dürrenmatt, ci si chiede se basti accontentarsi della pur presente satira contro lo strapotere dei ricchi, contro l’illusione di valori morali borghesi, contro l’ipocrisia del credo religioso, contro l’ingenuità dell’idealizzazione di modelli - oggi più che mai diffusa - che in realtà sono normali, fallaci esseri umani.
(Avverto il lettore che non vuole scoprire il lato migliore del libro, che in questo caso si rivela nel finale, di interrompere qui la lettura di questi miei pensieri. Andando oltre potrebbe perdere il gusto della sorpresa.)
Ovviamente la risposta è negativa, ed è espressa per mezzo di uno di quei sette personaggi pilastri dell’architettura etica di Arnolph: «Il miracolo avvenuto tra voi due è possibile e credibile soltanto grazie all’amore, e al di fuori dell’amore diventa una farsa». La chiave per me sta proprio in questa parola: «credibile». Se il lettore non crede all’amore di Chloé questo libro perde la sua credibilità, la costruzione della satira crolla e diventa semplicemente una farsa.
Invece, la rivelazione di “Greco cerca greca” è che si tratta di una storia d’amore fra Arnolph e la sfuggente Chloé, che appare come un miraggio troppo bello per essere vero, che contribuisce a quel sospetto di cui sopra, e che dopo qualche fugace apparizione svanisce come un sogno al risveglio. Con sospetto non estinto, troppo abituati alla Sfortuna, ovvero al male, guardiamo a questa palese rivelazione, poiché non può essere che tutto sia così luminoso, che l’amore possa effettivamente essere vero, che la fortuna sia così totale.
Chloé riapparirà, infine, in una scena quasi mistica, nelle vesti di una sacerdotessa di Afrodite, o forse lei stessa dea, una dea dell’amore sepolta sotto la sabbia di Grecia, una dea antica e riemersa, recante il miracolo dell’amore e della fortuna, del bene, al caro Arnolph, il quale a sua volta si sarà ravveduto e, passando per una furiosa metamorfosi in Ares, avrà distrutto la rigida e fasulla architettura eptastila per godere dei doni della dea in una nuova pace, forse più disillusa, ma più misurata, mutevole e quindi, infine, più umana.
“Greco cerca greca” è un libro portatore di una grande speranza, denso di temi e significati come solo Dürrenmatt sa produrre in poche pagine, senza risultare superficiale.
«L’amore è un miracolo che è sempre possibile, il male una realtà che è sempre presente»: ecco che quindi è inutile cercare il male all’interno del bene dell’amore, poiché se cercato sarà sempre trovato. La «via particolarmente difficile, la via della fortuna», è la speranzosa via dell’amore, che pur esiste oltre ogni sospetto.